Imparare a navigare l'incertezza: Futures Literacy e AI Fluency per un mondo in trasformazione
Le competenze necessarie per non subire, ma costruire il futuro nell'era dell'intelligenza artificiale
Viviamo in un’epoca di accelerazione senza precedenti. L’intelligenza artificiale generativa, dalla comparsa di ChatGPT in poi, ha innescato trasformazioni così rapide che le competenze considerate essenziali fino a ieri rischiano di diventare obsolete domani. La volatilità dei mercati, l’incertezza geopolitica, la complessità delle interconnessioni globali e l’ambiguità dei significati in un mondo sempre più mediato da algoritmi creano un contesto in cui le vecchie certezze vacillano.
In questo scenario, la domanda cruciale non è più “cosa dobbiamo imparare“, ma “come dobbiamo imparare a imparare” per rimanere rilevanti, creativi e capaci di agency in un mondo in costante trasformazione.
La risposta sta nello sviluppo di due meta-competenze complementari: la Futures Literacy e l’AI Fluency. Non si tratta di semplici abilità tecniche, ma di vere e proprie forme di alfabetizzazione che ridefiniscono il nostro rapporto con il futuro e con la tecnologia. Insieme, costituiscono l’infrastruttura cognitiva necessaria per affrontare l’incertezza e orientare il cambiamento.
L'accelerazione tecnologica e la moltiplicazione dell'incertezza
Per comprendere perché queste competenze siano diventate così urgenti, occorre partire dal contesto. Come evidenziato dal World Economic Forum nel Future of Jobs Report 2023, tre forze stanno contemporaneamente rimodellando lavoro, società e competenze necessarie: l’accelerazione del cambiamento tecnologico (trainato da AI, robotica, automazione), l’incertezza economica globale e la frammentazione geo-economica.
L’intelligenza artificiale, come definita dalla Commissione Europea nell’AI Act (2024), è “un sistema basato su una macchina che opera con vari livelli di autonomia e capacità di adattamento”, capace di generare output che “possono influenzare ambienti fisici o virtuali”. Questi sistemi introducono forme inedite di sfide: accelerano l’innovazione a ritmi mai visti prima, generano nuove forme di incertezza epistemica (cosa significa veramente un output generato dall’AI? Come possiamo fidarci?), intensificano la complessità delle interazioni tra agenti umani e artificiali, e introducono ambiguità semantiche profonde nei significati che produciamo e consumiamo.
Il risultato è un contesto in cui le competenze tradizionali che si acquisiscono una volta e si applicano per decenni non sono più sufficienti. Se il cambiamento tecnologico spinge la domanda di alfabetizzazione digitale e competenze tecnologiche avanzate, le tensioni globali e l’instabilità economica rendono imprescindibili le competenze soft: apprendimento continuo, agilità mentale, pensiero creativo e resilienza diventano fondamentali per navigare l’incertezza e generare valore anche in contesti di crisi.
Servono quindi competenze “meta”, capacità di secondo ordine che permettano di adattarsi continuamente, di immaginare scenari alternativi, di collaborare con sistemi intelligenti e di mantenere il controllo umano sulle decisioni che contano.
AI Literacy e AI Fluency: comprendere per non subire
Prima di parlare di AI Fluency, occorre un passo preliminare: l’AI Literacy, l’alfabetizzazione all’intelligenza artificiale. L’AI Act dell’Unione Europea (2024) le dedica un’attenzione definendola come l’insieme delle competenze e conoscenze che consentono alle persone che fornisco e sviluppano sistemi di AI e di chi la utilizza, di implementarla in modo consapevole e acquisire consapevolezza delle opportunità, dei rischi e dei possibili danni che essa può causare. Ma l’alfabetizzazione, per quanto necessaria, non è sufficiente. Serve un livello successivo di competenza: l’AI Fluency, intesa come capacità di interagire strategicamente con l’AI, di comunicare efficacemente con questi sistemi, di valutare criticamente i loro output e di agire con responsabilità.
Il framework proposto da Anthropic (2025) offre una guida particolarmente chiara per comprendere cosa significhi essere “fluent” nell’uso dell’AI. La fluency si articola in quattro dimensioni, che formano un acronimo eloquente, le “4D”:
Delegation: la capacità strategica di decidere quando e per quali compiti è opportuno coinvolgere l’AI. Non tutto va delegato, non tutto può essere automatizzato. La delegation implica una scelta strategica: quali attività possono essere supportate dall’AI mantenendo il controllo umano dove necessario? Questa competenza richiede una comprensione profonda sia delle capacità dell’AI sia del valore unico dell’intelligenza umana.
Description: l’abilità comunicativa di formulare istruzioni chiare, contestualizzate e comprensibili per l’AI. Il “prompting”, l’arte di comunicare con i sistemi AI, è diventato una competenza professionale a se stante. Una buona descrizione non è solo precisa, ma anticipa ambiguità, fornisce contesto, e può evolversi in vere e proprie conversazioni iterative che affinano progressivamente il risultato desiderato.
Discernment: la competenza critica nel valutare gli output generati dall’AI. I sistemi generativi possono produrre contenuti convincenti ma errati, perpetuare bias nascosti nei dati di addestramento, o generare risposte che sembrano appropriate ma mancano di profondità. Il discernimento implica saper riconoscere errori, incoerenze, risultati non pertinenti, e decidere consapevolmente se e come utilizzarli.
Diligence: l’impegno a usare l’AI in modo etico, trasparente e responsabile. Include la consapevolezza dei limiti dell’AI, il rispetto dei diritti delle persone (privacy, proprietà intellettuale, dignità) e la cura nel monitorare gli impatti delle decisioni supportate da sistemi intelligenti.
Futures Literacy: usare il futuro come lente critica
Parallelamente all’AI Fluency, esiste una seconda meta-competenza fondamentale: la Futures Literacy. L’UNESCO (2024), attraverso il suo programma Futures Literacy & Foresight, la definisce come la capacità di immaginare scenari alternativi e di guidare il cambiamento in modo proattivo.
A differenza della previsione tradizionale, che cerca di ipotizzare cosa accadrà nel futuro, la Futures Literacy parte da un presupposto radicale: il futuro non è unico, ma plurale. Esistono futuri possibili, plausibili, probabili e preferibili. L’approccio dell’UNESCO invita a esplorare questa molteplicità per liberarsi dalle narrazioni dominanti e spesso limitanti che condizionano la nostra visione di ciò che verrà.
La Futures Literacy si sviluppa attraverso tre dimensioni interconnesse:
luce dei futuri possibili.
Il Futures Thinking come palestra mentale
Ma come si sviluppa concretamente la Futures Literacy? Attraverso il Futures Thinking, una disciplina che da oltre cinquant’anni, grazie al lavoro pionieristico dell’Institute for the Future in California, elabora metodi e strumenti per coltivare un mindset orientato al futuro.
Alla base del Futures Thinking stanno tre principi fondamentali, come sintetizza Marina Gorbis, direttrice esecutiva dell’Institute for the Future (IFTF), nel suo articolo “5 Principles for Thinking Like a Futurist” (2019):
1. Il futuro non è unico, ma plurale perché esistono sempre molteplici futuri possibili
2. Il “pensiero futuribile” può essere esercitato e appreso, non è un dono innato ma una capacità allenabile
3. Ognuno ha agency per orientare il futuro verso ciò che ritiene preferibile, il futuro non “accade” semplicemente, si costruisce
Come scrive Gorbis:
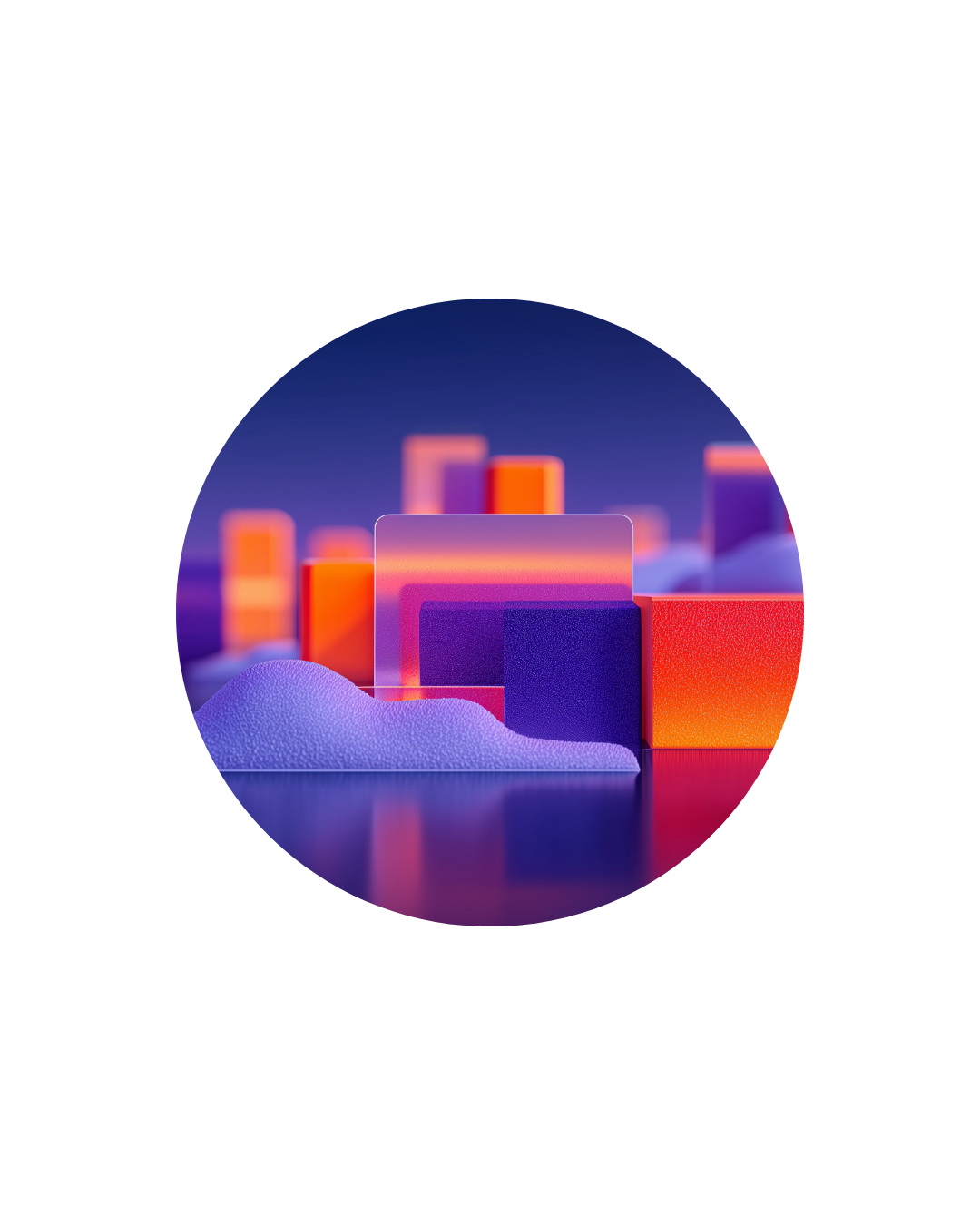
«Thinking about the future is also about imagining. It's about transforming how we think. It's about creating a map to the future and looking for the big areas of opportunity [...] The future doesn't just happen to us. We have agency in imagining and creating the kind of future we want to live in, and we can take actions to get us there. »
La futurologa Jane McGonigal, nel suo libro “Imaginable: How to See the Future Coming and Feel Ready for Anything” (2022), ha sviluppato toolkit pratici per esercitare competenze chiave del Futures Thinking:
Un concetto particolarmente potente elaborato da McGonigal (2022) è quello di “Urgent Optimism” (ottimismo urgente): una mentalità che combina la capacità di anticipare il futuro con la motivazione ad agire subito, anche in presenza di ostacoli e incertezze. Come scrive McGonigal:

«Urgent optimism is knowing that you have agency and unique talents, skills, and life experiences to create the world you want. It's not staying up all night worrying about what might happen. Rather, it's jumping out of bed every morning with a fire inside, ready to act.»
Non è un ottimismo ingenuo o passivo, ma un sentimento equilibrato che riconosce le sfide del futuro mantenendo una fiducia lucida nella possibilità di affrontarle.
L’urgent optimism si basa su tre elementi:
La sinergia necessaria: quando AI Fluency incontra Futures Literacy
Ciò che emerge con chiarezza è che AI Fluency e Futures Literacy non sono competenze separate, ma profondamente interconnesse. La prima senza la seconda rischia di limitarsi a uno sguardo troppo appiattito sul presente, perdendo la dimensione di visione. La seconda senza la prima rischia di rimanere astratta, incapace di confrontarsi con gli strumenti concreti che stanno rimodellando il presente.
Insieme, invece, formano un ecosistema di competenze che abilita una “cittadinanza digitale attiva” e una “professionalità evoluta”. Se l’AI Literacy fornisce le basi per comprendere e gestire l’AI in modo sicuro, l’AI Fluency consente di sfruttarne il potenziale in modo creativo, critico e responsabile. E la Futures Literacy fornisce la cornice orientativa: verso dove vogliamo andare? Quali futuri vogliamo rendere più probabili?
A partire da questa sinergia, possiamo definire alcuni scenari di applicazione:
Design e l’innovazione: l’AI può generare rapidamente prototipi e scenari, ma è la Futures Literacy che permette di immaginare futuri desiderabili verso cui orientare la progettazione, e l’AI Fluency che consente di usare questi strumenti in modo strategico anziché subire passivamente le soluzioni che propongono.
Ricerca sociale: l’AI può aiutare a identificare pattern e segnali deboli in grandi quantità di dati, ma è la Futures Literacy che permette di interpretare questi segnali come indizi di possibili futuri, e l’AI Fluency che garantisce un uso critico degli strumenti analitici.
Educazione: l’AI può personalizzare percorsi di apprendimento e fornire feedback immediato, ma è la Futures Literacy che aiuta studenti e docenti a immaginare quali competenze saranno rilevanti domani, e l’AI Fluency che assicura che la tecnologia amplifichi e non sostituisca l’apprendimento profondo.
Organizzazioni: l’AI può ottimizzare processi e supportare decisioni, ma è la Futures Literacy che permette di anticipare discontinuità e immaginare trasformazioni strategiche, e l’AI Fluency che garantisce un’adozione consapevole della tecnologia.
Formare alla complessità: implicazioni per l'educazione
Cosa significa tutto questo per l’educazione e la formazione? Innanzitutto, un ripensamento radicale degli obiettivi. Non possiamo più limitarci a trasmettere contenuti o competenze specifiche, destinate a diventare rapidamente obsolete. Dobbiamo formare alla “capacità di navigare l’incertezza“, alle “meta-abilità” che permettono di continuare ad apprendere, adattarsi e innovare.
Questo richiede diversi cambiamenti:
Dal contenuto al processo: più che accumulare conoscenze, occorre imparare a cercarle, valutarle, sintetizzarle e applicarle in contesti nuovi. L’AI può supportare queste attività, ma solo se sviluppiamo la fluency per usarla bene.
Dalla certezza all’incertezza: l’educazione tradizionale premia le risposte corrette a domande note. L’educazione per il mondo contemporaneo deve insegnare a gestire l’ambiguità, a formulare buone domande, a esplorare molteplici risposte possibili. La Futures Literacy diventa qui centrale.
Dall’individuale al collettivo: molte delle sfide contemporanee richiedono intelligenza collettiva, capacità di collaborare con persone diverse, di negoziare visioni, di co-creare soluzioni. I processi partecipativi del Futures Thinking sono una palestra ideale per queste competenze.
Dall’astrazione all’esperienza: le competenze si sviluppano attraverso l’uso, non attraverso lo studio astratto. Serve creare contesti in cui studenti e professionisti possano sperimentare concretamente l’uso dell’AI, immaginare scenari futuri e riflettere sulle implicazioni delle proprie scelte.
Dall’adozione alla creazione: in un’epoca di abbondanza informativa e di strumenti generativi potenti, la competenza cruciale non è la capacità di creare, non solo di adottare correttamente. Creare scenari, creare prototipi, creare visioni condivise.
Riferimenti bibliografici
Anthropic (2025), AI Fluency: Framework & Foundations. Learn to collaborate with AI systems effectively, efficiently, ethically, and safely
Gorbis, M. (2019), 5 Principles for Thinking Like a Futurist, EDUCAUSE Review
McGonigal, J. (2022), Imaginable: How to See the Future Coming and Feel Ready for Anything—even Things That Feel Impossible Today, Transworld Digital
UNESCO (2024), Futures Literacy & Foresight
Unione Europea (2024), Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio – AI Act
World Economic Forum (2023), Future of Jobs Report 2025
Condividi tramite